I numerosi e qualificati critici che si sono occupati fin dagli anni Cinquanta di Renzo Biasion hanno ogni volta sottolineato la fondamentale caratteristica di questo straordinario personaggio: di essere disegnatore e incisore puntiglioso, e insieme caldo interprete della realtà concreta, restituita attraverso luci soffuse e atmosfere vaporose; con, a seconda dei casi, o addirittura contemporaneamente, una tagliente lucidità di tratto e una morbidezza pastosa di colore. Un artista eccezionale, che potremmo definire eclettico, considerate le caratteristiche della sua opera cui abbiamo fatto cenno; ma l’eclettismo di solito presuppone una varietà di orientamenti l’uno diverso dall’altro: Biasion invece è sempre lo stesso, in modo riconoscibile; quella formula intensa e nitida nella quale lo identifichiamo, la cui diretta matrice è il cosiddetto “stile Novecento”, ne sottolinea una chiara personalità; e la ritroviamo dai ritratti ai paesaggi, dalle opere di piccolo formato e dalle vedute ravvicinate ai grandi dipinti e alle vedute profonde. Ovviamente alla sua precisa peculiarità non è estraneo uno sviluppo nel tempo, cioè l’identificabile successione di fasi diverse del suo operare, anche con predilezioni di argomenti e tematiche. A questo proposito è opportuno sottolineare l’interesse, negli anni Cinquanta, per il tema delle case operaie, o delle periferie con edifici che si sarebbero poi identificati come archeologia industriale; e, negli anni Settanta, l’affascinante sequenza dei simbolici ritratti frontali. Personaggio di forte comunicativa e insieme di grande complessità. Con la sua biografia potremmo identificarne la fisionomia nell’incontro tra la cultura veneziana e bolognese; ma come escludere l’influenza dell’area veneta e fiorentina e la consapevolezza del menzionato Novecento lombardo? È sempre lo stesso ma sempre sensibile agli incontri e ai confronti.
Rossana Bossaglia (2004)
Le periferie
Le periferie urbane costituiscono uno dei motivi dominanti della poetica di Biasion, quasi una metafora visiva di un modo di interpretare una parte della realtà italiana del nostro tempo in chiave antropologica, sociologica e spaziotemporale. Se agli inizi, come abbiamo notato, Biasion affronta il tema con un piglio non programmatico ed espressionistico, con una carica, cioè, passionale, in seguito, come vedremo, rappresenta i vari scenari urbani attraverso una meditazione rigorosa e implacabile, fino a restituirci immagini cristallizzate in mira bili composizioni spaziali. Sembra quasi che l’artista aspiri a costruire caseggiati, strade, complessi architettonici, considerandoli emblemi di una possibile eterna solitudine: e non tanto per la totale assenza di figure umane, quanto invece per quel senso metafisico conferito alle varie strutture volumetriche e prospettiche, dipinte con una contenuta carica emotiva, capace di imprimere alla visione un’incontenibile forza e saldezza di superficie quando si sofferma sulla rappresentazione dei “pieni” e una misteriosa estensione in profondità nel realizzare i “vuoti”. Se l’assenza della figura umana crea un senso di sgomento, una sorta di “serena disperazione” (è il titolo di una raccolta poetica di Saba), la presenza ossessiva di segnali e insegne stradali, di reti metalliche e transenne, di palizzate, cancelli, pali della luce, manifesti pubblicitari incollati sulle superfici di varie costruzioni e biancheria stesa al sole in certi casermoni di periferia – questa presenza diventa essa stessa “personaggio” carico di una misteriosa e inquietante vitalità antropomorfica. Le finestre, buie e nere, sembrano sovente occhi chiusi nella chiara diffusione della luce, che sfiora muri corrosi dalle intemperie, e i camini appaiono simili a braccia che si alzano verso il cielo. …Il dipinto di Biasion si impone per la straordinaria complessità compositiva (soprattutto nei primi piani), tesa a esaltare una sorta di scontrosa drammaticità, quasi un riscatto polemico delle povere baracche, dei pali neri e bianchi che formano scattanti strutture geometrizzanti entro le quali il colore si contrappone, in un serrato gioco di tonalità calde, al cupo splendore dei blu profondi e dei grigi funerei. Per Biasion il muro di una casa non è più, come per un pittore impressionista, una superficie intrisa di tremolanti dolcezze primaverili o autunnali, ma un piano sul quale “solidificare” recondite analogie. Stratificazioni di colori, manifesti o insegne pubblicitarie, finestre spalancate o chiuse come occhi impenetrabili danno luogo a un continuo “dialogo” segreto, si no a trasformare le superfici murarie di anonimi caseggiati urbani in conglomerati di vita intensamente vissuta. L’impressione si trasforma, perciò, in espressione: la materia si difende invano dagli attacchi dello spirito creativo del pittore. Ciò che gli fermenta nell’animo affiora nel ritmo di una pennellata, nell’attenta orditura spaziale, nella straordinaria compostezza e compenetrazione armoniosa delle varie zone cromatiche che definiscono uno spazio umano e poetico – un luogo di silenziose meditazioni sul quale è trascorso inesorabile il tempo che tutto trasforma. La mostra torinese consacra “ufficialmente” un genere, quello delle periferie, che costituisce indubbiamente uno dei cardini su cui poggia la ricerca espressiva di Renzo Biasion, sempre pronto a captare, oltre le apparenze esterne del mondo, un significato morale ed esistenziale. Un genere affrontato, come è noto, anche da altri artisti contemporanei, e in particolare da Mario Sironi e da Renzo Vespignani, ma con risultati profondamente diversi sia sul piano ideologico sia su quello formale. … Con le periferie e la visione più o meno ravvicinata di case singole o di una parte di esse, Biasion crea uno dei capitoli più originali del suo lungo percorso operativo e creativo, ponendosi come una delle personalità più importanti della pittura italiana della seconda metà del Novecento.
Ottorino Stefani (1993)
La caratteristica di questi ritratti di edifici, veramente come i ‘volti di pietra’ o di ‘intonaco’ di un’urbanistica dell’anima, non sta soltanto nella loro interiorizzazione, sta nella grazia tutta impressionista dello smalto, nella felicità con cui l’artista rampica di balcone in facciata, di finestra in tetto, coi suoi verdi smaglianti, componendo il plein air con l’accigliata periferia bolognese, la notazione sensibile con una sorta di Metafisica. Certo non si possono comprendere questi casoni sui prati, senza i ‘giardini’ che vi si sono creati attorno: magri, coltivati con candore e pazienza, un mandarino stento, qualche metro quadrato di ortaggi, le piante in vaso, i rampicanti ai balconi; un lussureggiare che si ritrova soltanto nel pennello dell’artista, nella misura in cui egli sa scoprire anche qui, come ieri dentro la sua stanza, la festa del plein air. Non si tratta di una scoperta puramente edonistica, direi estranea all’argomento, quasi che il pittore volesse trovare il bello per dispetto agli abitanti dei suoi casoni; direi anzi che il bello finale di queste opere, filtrate nel clima impressionista e restate così assorte e gravi, sta nella implicita presenza, niente affatto casuale, dell’uomo, il lavoratore medio, il pensionato, sta nel sentimento di un quartiere di gente che vive con impegno umano e con fatica.
Marcello Venturoli (1973)
Biasion ha da tempo ripreso la serie degli “interni”, già iniziata negli anni fra il 1946 e il 1947, dove, da una pacata ed elegante sommarietà rappresentativa, si trascorre il più spesso ad una esaltazione del puro segno e del puro colore, ad una ricerca di valori al margine dell’astrazione, che tuttavia, ancorati come restano alla natura a mezzo di fili sia pure occasionali, vietano pur sempre di considerare questa pittura come una mera calligrafia, definendosi essa piuttosto come assunzione del dato sensibile a una fantasia staccata di puri rapporti.
Sergio Solmi (1949)
Disegnatore eccellente, istintivo, egli dissimula il disegno nel colore senza annullarne la tranquilla forza; ed il colore, a sua volta, è trepido, vibrato, sensibile sempre alla qualità della luce che varia con sfumature impercettibili, di rara delicatezza.
Marziano Bernardi (1953)
Pittura che si arricchisce di toni, che si tende in una duttile lingua, traendo dalle occasioni una schiva poesia, un accordo tiepido e umano: così nei paesaggi, anche d’esigua misura, che sono assai più di bozzetti, e nei ritratti, appuntati ad un’attitudine o ad un carattere, Biasion mette a fuoco una esperienza dal vero che è storia intima delle cose e del sentimento.
Lamberto Priori (1955)
Un buon ragazzo di Treviso, col gusto del colore nel sangue, e della campagna, della provincia. Un veritiero, ma adorno di fantasie volanti e colorate, lievi, rosa e celesti, chiare. E del ragazzo veneto serba tuttora, a quarantaquattro anni, anche una simpatica, furba socievolezza e certa bonaria, sorridente, perdonabile e anzi amabile abilità. Che poi -sia ripetuto a lode -non gli servono davvero gran che: Renzo Biasion ama naturalmente l’umiltà, il colore della campagna contadina e la vita in provincia. Simile al paesano suo Comisso, gli piacerebbe vivere e sognare in mezzo ai campi e guardare con distacco e con affetto insieme le stagioni che vanno ripetendosi sempre nuove e la gente che appare e scompare in un’aria indicibile, miracolosa, pianamente pittorica.
Leonardo Borgese (1958)
Biasion è colorista scaltro, smaliziato. È quel che si dice un dotato. Eppure le sue opere rivelano un ‘assoluta castigatezza, e nei toni, e nell’economia dei colori stessi. Quello di Biasion è un canto sottovoce, un’apertura a semitono. Ed è a questa prospettiva cromatica – ch’è prospettiva sentimentale, alla fine –che si condizionano i termini coloristi ci usati: nessun ricorso al tono folgorante, al colpo d’effetto, dunque, ma un silenzioso muoversi in unità atmosferica. Ed ecco le piazze venete, i giardinetti delle case di periferia piccolo borghesi: paesaggi un poco tristi che portano, nel rigore delle loro strutture, il sentimento naturale che celano nella quotidiana realtà.
Carlo Munari (1954)
Biasion ha un piccolo piccolo mondo. Treviso, il Veneto, Verona e le terre dei laghi. Poi la periferia di Torino, la periferia di Milano. Ci sono tutte? Non credo. Le vedute che preferisco sono quelle venete e bolognesi. Si sente una frequenza più permanente, un’ aria di casa, una comprensione “reciproca” tra pittore e paesaggio. Una casa di Treviso con un praticello verdolino molto mi piace. Chi ha scritto, parlando di queste vedute, “impressionismo-veneto” ha scritto giusto. Biasion ha conosciuto e frequentato Semeghini? Non so. Ma c’è nelle sue telette un balsamo luministico, un’arietta fluida e umida che ricorda certe sonatine in sordina di Semeghini. Meglio non abusare di arpeggi. E infatti Biasion da uomo delicato si tiene fuori da taluni ballabili un po’ facili. Forse la preoccupazione di essere leggibile fino all’ultima frase lo rende più sottolineato del necessario. Ma è per un eccesso di rispetto verso le cose della natura.
Raffaele Corrieri (1958)
Stagione fredde appaiono nel taglio quasi sempre orizzonta le dei suoi paesaggi, ma intenerite da non sai che presenti mento di tepore, di peluria primaverile. Gli interni di casa hanno il quieto disordine delle stanze abitate.
Marco Valsecchi (1958)
Il suo orizzonte non è più solamente quello di Treviso e del la campagna veronese: ma, anche nelle periferie di Bologna o di Torino o di Milano il suo tema è quello della campagna italiana, orti, crocicchi, case solitarie e giardini, senza camuffare la nostra cara Padania alla maniera, per esempio, di un Vlaminck o di un Utrillo; felice di essere un pittore che vede bene e che ama i colori del proprio paese, con una penetrazione affettuosa e con un sentimento che sa trovare un valore elegiaco anche nel più umile scorcio suburbano. Tonalmente più profonda che nelle prime esperienze, la sua pittura si è svincolata dai liti del chiarismo senza perdere la propria grazie evocativa. E la pittura, vorremmo dire, di un buon viandante, che ogni tanto siede su un pilastrino, si guarda attorno, e scopre i motivi della bellezza agreste senza sentir la necessità di complicarli, con un discorso limpido, sereno, riposante. Era il modo di scrivere, ai suoi tempi, di Panzini, quando si faceva pellegrino in bicicletta.
Orio Vergani (1958)
… è questa specie di spettacolo che sta per finire che egli ama ritrarre con quella sua precisa , asciutta pittura senza or pelli e sotterfugi pittorici, prendendo di petto il soggetto con la pulizia e fermezza che era la base della grande arte veneta del 400. I suoi ritratti sono condotti con grande compostez za e con un disegno attento, sapiente, acuto, assoluto, e il tono dei colori è tanto vero quanto inventato; ne risultano opere nuove e classiche a un tempo.
Enzo Moretti (1960)
È piccolo il mondo dei contenuti; una serie di interni e di case rosse nel verde dei giardini, e qualche natura morta e qualche ritratto. Ma la limpidità di visione lo innalza molto più su degli spunti oggettivi, lo trasferisce in un’atmosfera raccolta, dominata dal silenzio e dal timbro cordiale della illuminazione . Il realismo di Biasion è un atto di fiducia nel le cose che stanno fuori di noi e sono il termine dei nostri pensieri; nella stessa intonazione elegiaca in cui l’indagine del reale si unifica e si trasfigura, si fa evidente il segno del nostro tempo: un’ansia trepida, un velo di malinconia , una consapevolezza del tramonto di antiche certezze e tuttavia una speranza di recuperarle.
Fortunato Bellonzi (1962)
Il trevigiano Biasion si è trapiantato, da anni, nella nostra città (Bologna): in questo pezzo di terra emiliana. Qui, tranquillo, sereno ma attento agli umori delle cose e della gente, ha trasferito il sentimento della sua domesticità, della sua pacatezza veneziana. Ha portato con sé, con l’accento di una nostalgia antica, la vitalità, la ricchezza, -tutta passata nel suo colore accordato a questa nostra distesa, opaca luce bolognese, -di una terra che, nella pittura, sembrava cresciuta per dare felicità e ristoro a chi la guarda, a chi se la porta nella memoria. Un allargamento appassionato del vivere, del daffare quotidiano. E servono, queste pitture di Biasion, a darci un poco di speranza alle ore della giornata, così lunghe.
Giuseppe Raimondi (1962)
Non v’è soluzione di continuità tra il Biasion critico, il Biasion pittore ed il Biasion narratore, ma non v’è neppure rottura o salto nello stesso cammino artistico percorso dal Nostro. Il pittore rimane decisamente fedele alla figurazione perché senza di questa non potrebbe esprimersi, non riuscirebbe a estrinsecarsi oggettivamente, pur nell’empito fantastico, non troverebbe le vie più immediate per svolge re il proprio racconto colorato. Ed in un lungo racconto, policromo e vivo, misurato e fermo, si condensa la instancabile produzione pittorica e letteraria di Biasion, in un racconto lirico commosso, nel quale brillano la calda luce veneta, la cordiale umanità bolognese, il nostalgico clima egeo, che tanto ha nutrito l’artista, i persistenti richiami della solare cultura mediterranea.
Emilio Contini (1963)
E’ attraverso un lento e parsimonioso concedersi che il suo minuto mondo poetico si lascia dischiudere alla contemplazione, rivelandoci un “realtà nuova”, prima non esistente, abitata dalla poesia. E una vena sottile, intrisa di un certo intimismo, soffusa di cadenze crepuscolari, ma che ti conduce lontano, nel cielo della stanza, e ti riporta a casa. Con uno stile che si è maturato lentamente – temperando la radice veneta nell’innesto emiliano – l’artista ha percorso la “sua” strada con fedeltà e grande rettitudine, fin dagli anni dell’infanzia, quando tredicenne cominciò a dipingere peri ferie cittadine, ritratti e interni, che sarebbero poi diventa ti i temi classici della sua pittura.
Giorgio Ruggeri (1963)
… ma, ecco il punto: disegno sommesso e colore di dominio pubblico riescono a dare risultati inconfondibili quanto a personalità . Il quale fatto è già arte. Senza contare che il “vero” di Biasion l’avremo forse intuito nell’offerta che il mondo fa di se stesso ogni momento, ma lui, il Biasion l’ha riportato con immensa discrezione per nostro diletto, senza angustiarci di problemi: apparentemente, ma con una straordinaria capacità di essere riguardato e di parlare più profondo ad ogni lettura.
Corrado Corazza (1964)
Viva Biasion
che arguto e giulivo, poetico e onesto
tien vivo e desto il figurativo.
Mino Maccari (1965)
Tra i temi maggiormente amati da Biasion, oltre alle periferie e ai sobborghi cittadini sorpresi nei silenzi più assoluti, che possono tuttavia sottintendere passioni e drammi dell’esistere quotidiano, quello degli interni acquista un rilievo particolare, riconfermando la predilezione dell’artista a riconoscere negli ambienti il segno degli affetti, quanto differenzia l’indistinto, il generico, dal distinto, da quanto è fatto dall’uomo e per l’uomo. Per questo gli interni di Biasion risultano gremiti di oggetti familiari, visti di sovente attraverso una porta socchiusa simile a uno sguardo attento che pene tra in quanto sta dentro: scaffali colmi di libri, quadri e stampe, sedie e divani, letti e fiori, conchiglie e soprammobili… sono oggetti che l’occhio di Biasion trasforma in personaggi, in esseri ricchi di una loro storia segreta, che sfugge ai languori crepuscolari perché sorretta da una vigoria che salva il sentimento da ogni pericolo di scadimento.
Salvatore Maugeri (1973)
Ogni elemento del paesaggio ha il suo peso e la sua misura, ma la pittura che lo esprime assume il significato di evocazione, di riporto, cioè, di un’altra cosa che ci sfugge e che sentiamo presente quale protagonista della nostra realtà. Nella interpretazione dunque di Biasion c’è un sottile filo di magia che da una realtà visiva ci conduce ad una realtà introspettiva e mentale. Analizzare questo filo di magia non è facile, perché Biasion sa nascondere con pudore quel palpito di sentimento che vibra nella sua visione pittorica. Ma se guardiamo in fondo all’immagine c’è quell’aerea nota patetica, che spesso distingue la pittura dei veneti: gentilezza d’animo, disposizione a rendere compartecipi le cose più usuali, come fossero crea ture, ad un pensiero più alto che le accoglie nel fluire inconscio degli stati d’animo, ora per ora della giornata.
Guido Perocco (1970)
Ma ciò che andrà sottolineato come particolarmente significativo nello sviluppo di questa esperienza acquafortistica di Renzo Biasion, rivelatasi in grado di catturare l’attenzione e l’interesse del lettore sino al punto di renderlo pienamente partecipe delle ricerche e delle emozioni dell’artista e, quindi, di testimoniare nel modo più convincente della propria validità, sarà precisamente il fatto di essere stata essa con dotta e garantita, nel raggiungimento delle proprie più felici soluzioni, dall’intervento di un processo esclusivamente basato sul puro impiego delle tecniche incisorie cosiddette “classico-tradizionali”, e che nessun altro procedimento tecnico grafico avrebbe potuto sostituire nell’ottenimento dei risultati ricercati e conseguiti.
Giorgio Trentin (1971)
… Renzo Biasion, figura solitaria nel panorama dell’arte ita liana d’oggi … è straordinario quando raffigura un fiore o una porta socchiusa simile a uno sguardo attento che pene tra in quanto sta dentro: scaffali colmi di libri, quadri e stam pe, sedie e divani, letti e fiori, conchiglie e soprammobili … sono oggetti che l’occhio di Biasion trasforma in personag gi, in esseri ricchi di una loro storia segreta, che sfugge ai languori crepuscolari perché sorretta da una vigoria che sal va il sentimento da ogni pericolo di scadimento.
Luigi Carluccio (1973)
Del nudo, Biasion conosce tutte le possibilità; egli sa bene quale ricchezza di immagini e di sensazioni può offrire ad un artista la figura umana. Egli con l’estrosità di un tono o di una solvenza cromatica, con le sue puntualizzazioni espressive, con una impaginazione sempre nuova, mostra di possedere un suo modo di entrare in rapporto con la realtà, di mettersi a colloquio con il suo personaggio, rivelando il dono dell’immediatezza ch’egli possiede in pieno e le capacità di acuto osservatore.
Armando Nocentini (1973)
Le acqueforti di Biasion non sono un anticipo delle sue tappe pittoriche, né possono essere considerate autonomamente dalla sua pittura. Direi piuttosto che siano state sovente la verifica dei motivi e dei modi del suo post impressionismo, proiezione o specchio di essi. I singoli momenti sono infatti rispecchiati dalla pittura nella grafica e acquistano diverso spessore di fantasia, sono più o meno documento, più o me no immagine liberata di figura o di paesaggio, nella misura in cui la tappa pittorica è stata ricca e conclusiva a monte del suo iter. Ciò non significa che si debba parlare delle centinaia di stampe e di disegni di Biasion come di album di svaghi, di assaggi di bella mano; è a mio avviso un complemento indispensabile, alla scoperta pittorica…
Marcello Venturoli (1973)
Accettiamola ora per buona, l’idea delle pietre piccole che Biasion asserisce di portare all’edificio dell’arte, se non altro pensando all’aspetto dimesso, alla quotidianità dei suoi soggetti delle periferie, magari con dei panni stesi, delle conchiglie, dei fiori spesso secchi, dei mobili sottili e sghembi, delle finestre. Non si prestano, no, non sembrano prestarsi al discorso difficile, non sembrano aprirsi su spazi metafisici, né sembrano operare al rovesciamento delle strutture di questo nostro mondo. Sono Iì, in qualche modo abbandonati e pacati, lasciati a se stessi, si direbbe, in una specie di silenzio un po’ sconfitto, dal quale però occhieggiano maliziosi. Esili, modesti, a tutta prima vi danno l’impressione di starsene ritrosi, chiusi dentro la loro scorza. Ma provate a tenerli un po’ a lungo nella vostra stanza; via via sono diventate presenze vicine e occasioni di colloquio. Si lasciano guardare e a loro volta ci guardano. Ci fanno compagnia.
Mario Pomilio (1976)
… Renzo Biasion è il miracoloso interprete di questa realtà quotidiana e intemporale; il solo, tra tante velleità e clamori di “adeguazione al nostro tempo”, ad averla contemplata nel la sua verità e ricreata in immagini di altissima poesia. Con lui – è questo finalmente il suo segreto, ed era il solo riscatto possibile -i dintorni delle città sono usciti dalla pittura di paesaggio per entrare in un genere altrettanto classico, ma che nella sua purezza non tollera figure o movimenti di sorta… Le periferie di Biasion non sono “vedute”: le sue immobili e silenziose collocazioni sono ex paesaggi trasformati per sempre in “oggetti di ferma”, come fu tradotto in italiano still level, verso il 1650 prima di diventare “natura morta”.
Carlo Fruttero – Franco Lucentini (1978)
… Renzo Biasion è eccellente disegnatore, di conseguenza è un ottimo incisore. Ho sempre ammirato in lui la semplicità con la quale disegna e poi incide le sue acqueforti. Un foglio di Biasion inciso all’acquaforte risulterà riconoscibile di primo acchito tra mille (cosa rara oggi…). Le sue poetiche periferie sono inconfondibili, come le sue figure, i fiori, gli intimi silenzi interni…
Walter Piacesi (1979)
… ha riunito una bella scelta di acqueforti ed acquarelli: colmi di luce questi, mentre nelle pagine incise l’eloquenza sembra affidarsi tutta alla concretezza delle “cose” delineate col segno più asciutto.
Angelo Dragone (1980)
… Le incisioni di Renzo Biasion, pur essendo molto diverse da quelle di Bartolini, mi danno la stessa emozione poetica. Una realtà vissuta attraverso un profilo di fanciulla, un paesaggio di periferia dove il semplice elemento di un moscone diventa protagonista sullo sfondo d’un ricordo della Grecia. Invidio la sua capacità di saper attingere dalle piccole e dal le grandi cose della vita.
Emilio Greco (1980)
E come ci accade ogni qual volta che, intendendo recupera re l’immagine abbandonata per esigenze di copione di un at tore che ci è caro, ricorriamo alle interpretazioni che più ce lo resero familiare, così per Biasion amiamo rituffarci in quel mare splendido che è la sua incisione: una espressione tecnica e stilistica in cui “il professore” opera e parla dalla più simpatica e avvincente delle sue cattedre.
Tommaso Paloscia (1978)
Biasion appartiene a quella ristretta schiera di pittori che le idee chiare le ha avute quasi subito, ed ha cercato di dominare le difficoltà del cammino, inevitabili, con una sicurezza che non gli è mai venuta meno. Si dice questo perché la sua fede costante in un’espressione armonica pienamente figurativa è il fondamento della sua attività.
Rodolfo Bargelli (1979)
A Venezia con Biasion
O God, what great kindness
bave we done in times past
O God o the night
what great sorrow
Cometh unto us…
Ezra Pound
Quale nostro passato valore dimenticato presto ci meritava il dono di Venezia della sua meraviglia? Di quale gran dolore che tuttora ci aspetta ci risarciva anzitempo coll’essere come era Venezia? A tali domande non rispondono più il dio delle acque il dio della notte. Sprofondano con le città sotto il nostro orizzonte. Col male di una domanda non fatta di una risposta non giunta si va su acque in perpetuo turbate: su slontananti acque nere, una notte, una nostra Venezia congetturando tra quelle luci rade. Ma viene con le sue conchiglie col suo asso marino il sempreragazzo il tuttoterrestre Biasion. A sostentare capitelli, a spaziare gabbiani. Non ama – si dice – in verticale.
<p style=”text-align:right;”><em>Vittorio Sereni (1981)
“Votato alla versatilità come per una condanna, nell’ultima produzione Biasion ha messo a punto una strumentaria “specializzata” per generi e soggetti. Così l’olio gli serve per rendere lo spessore chiuso e massivo di una veduta urbana, il pastello la morbidezza di un’epidermide svelata, il bulino per “scrivere” la struttura portante di tutto. L’acquerello, il più incorporeo, l’ha consacrato in buona parte a Venezia, isola di luce che affiora nel suo chiarore di madreperla, con la cupola del Redentore alta e rigonfia come per una deformazione o un prodigio, che ormai, attraverso il tempo, non possono essere più solo ottici”.
Giuliano Serafini (1987)
Quello che sbalordisce del Biasion grafico è ancora una componente “manuale”: voglio dire che mi sembra straordinario che proprio quando l’artista dovrebbe scoprirsi faber in bottega, tra acidi, lastre e torchi, a memorizzare e reinventare a tavolino, al chiuso, impressioni e ricordi, è straordinario, dicevo, che lui invece compia quella che può definirsi un’eresia professionale, trasgredisca la regola e tenti l’impensabile, con l’uscirsene all’aperto, en plen air, la sua brava lastra e le punte in tasca, a incidere dal vivo. Dunque, si tratti di parole, colori o bulini, Biasion non può fare a meno di tradurre “in diretta” quanto gli capita sotto gli occhi.
Giuliano Serafini (1982)
Era pittore dai toni caldi, proprii della sua origine veneta, ma bolognese d’adozione e… con “trasferte” fiorentine. … I suoi paesaggi, con tonalità tenui, ci trasferiscono a Venezia, ripresa dalla laguna, come alla nostra San Luca, riservando al rosso vinoso delle vecchie case bolognesi di periferia un timbro marcato e un’affettuosità discorsiva.
Romeo Forni
Critica di Ottorino Stefani
… Certamente in Biasion non vi è mai stata, come in de Chirico, la riflessione teorica quasi ossessiva (soprattutto intorno al 1920) sul concetto di “classicismo” in rapporto alla cultura contemporanea. Tuttavia, se teniamo presenti dipinti come ‘Pensando alla Grecia’, del 1960, e molte opere grafiche e calcografiche, ci rendiamo conto che l’artista trasforma la lezione dei classici in un’esperienza che lo avvicina, in parte, a quanto de Chirico ha scritto a proposito del classicismo, considerandolo “un problema di sfrondatura e di potatura”, cioè una ricerca di sintesi organica della natura, platonicamente purificata dai suoi aspetti ingannevoli e cangianti, mediante un sapiente uso della linea: “Come lngres e i quattrocentisti italiani, così i pittori della Grecia antica vedevano solo nel disegno il fondo d’ogni grande arte. In questa specie di misticismo della linea, che caratterizza un’arte veramente classica, si può scorgere l’avversione per l’insieme delle masse inutili, per la soda polposità, estranea a ogni sottigliezza spirituale, e la tendenza a ridursi solo all’alfabeto religioso dei segni che formano il contorno di una figura o d’un oggetto”. Durante il suo lungo percorso operativo e creativo, coinvolto in una solitudine voluta con fermezza, Biasion è rimasto sostanzialmente fedele a tale principio, evitando, tuttavia, di applicarlo con rigore accademico. Infatti, egli ha saputo ritrovare un ordine interno alla sua visione rimanendo sempre a contatto con una realtà viva e pulsante, anche se spesso enigmatica e sfuggente. Pertanto il suo classicismo è espressione non tanto di teorie platoniche, quanto, invece, di una concezione estetica aristotelica: legata quindi alla tradizione artistica veneta. Una concezione che non cerca valori ideali astratti,ma che affonda le radici nel campo dell’esperienza diretta e della natura Certamente come in tutte le vicende umane (di cui l’arte costituisce un poetico “rispecchiamento” espressivo), le contaminazioni sono non solo possibili, ma quasi inevitabili. Del resto, abbiamo più volte sottolineato che nell’arte di Biasion affiorano momenti in cui lo “spirito della geometria” diventa una struttura talmente perentoria da far pensare a una dimensione del mondo purificata da ogni riferimento con tingente; in altri momenti, invece, i fermenti espressionistici e realistici sembrano quasi prevalere sul dato razionale e ideale. Tuttavia, nel fondo della sua ricerca, rimane sempre vivo il desiderio di esprimere la segreta bellezza di ogni aspetto visibile della realtà, riportando tale bellezza nell’ambito di una struttura formale di impronta classica. Si tratta, in ogni caso, di un classicismo svincolato da qualsiasi norma inflessibile, che lascia trasparire le leggi del sentimento e dell’armonia ritrovati, quasi per il miracolo di una straordinaria stratificazione cul turale, nel cuore stesso della storia e della natura.
(dalla monografia ‘Biasion’, Milano, Electa,1993)

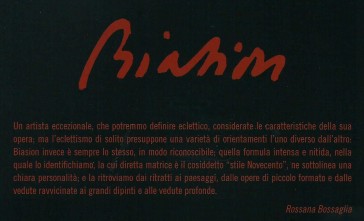





















E’ possibile sapere da dove proviene la citazione di Fruttero & Lucentini? E se abbiate notizie precise di articoli o introduzioni da loro dedicate a Biasion? Grazie anticipatamente, Giacomo
"Mi piace"Piace a 1 persona